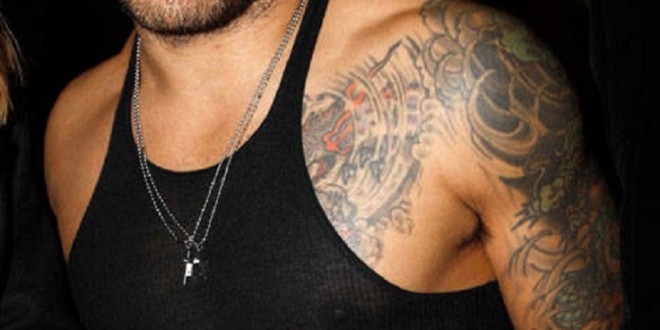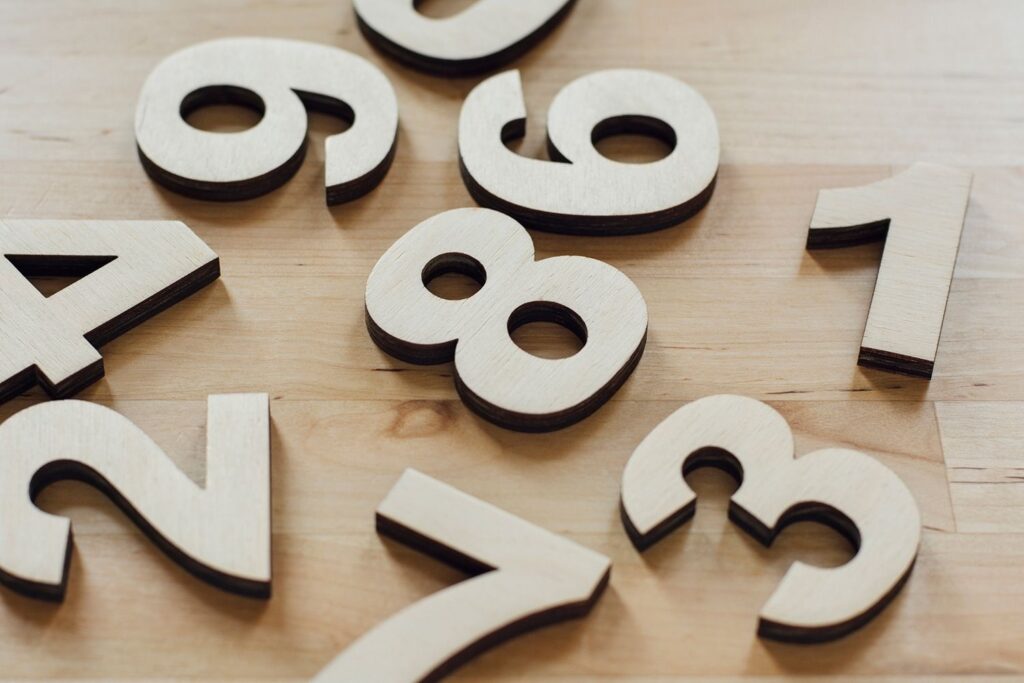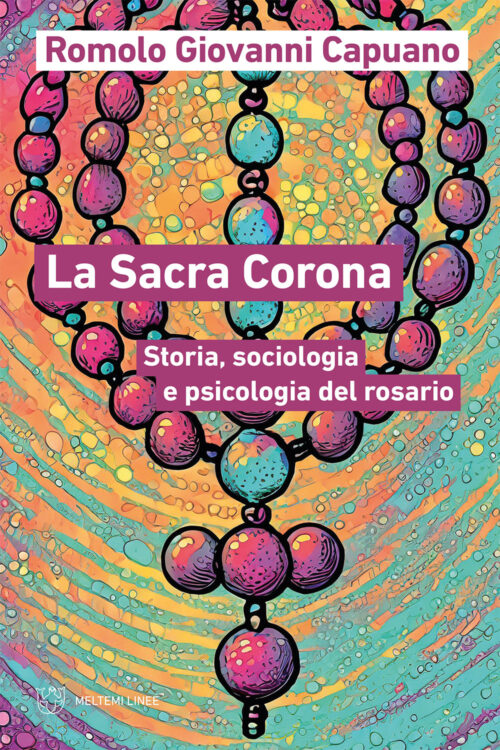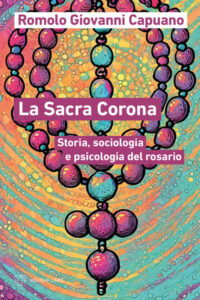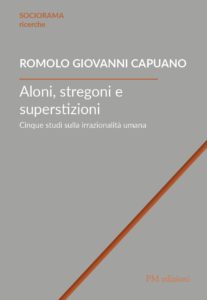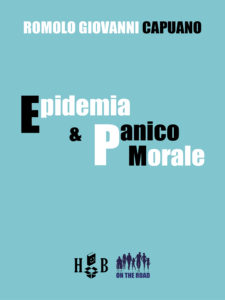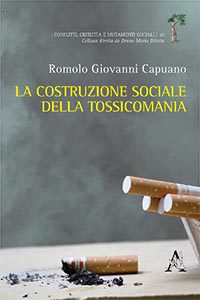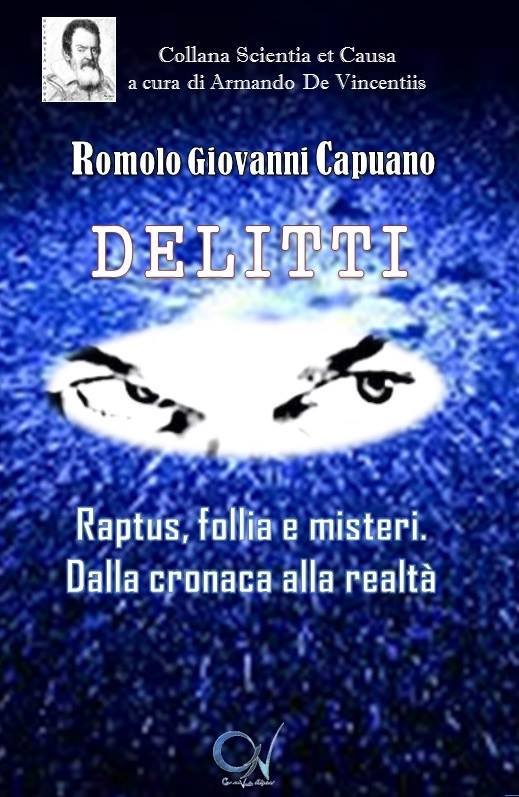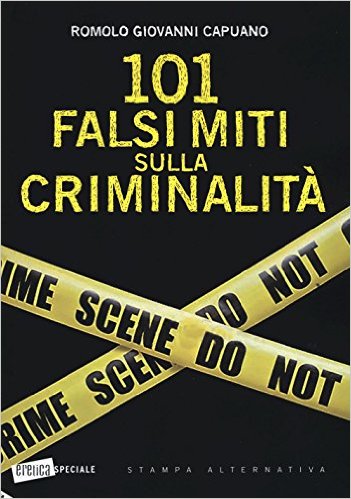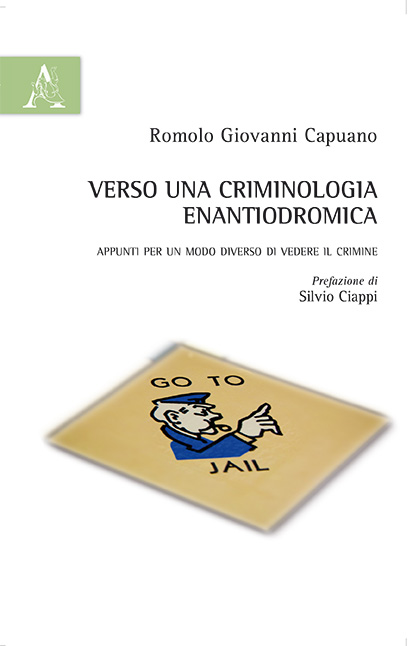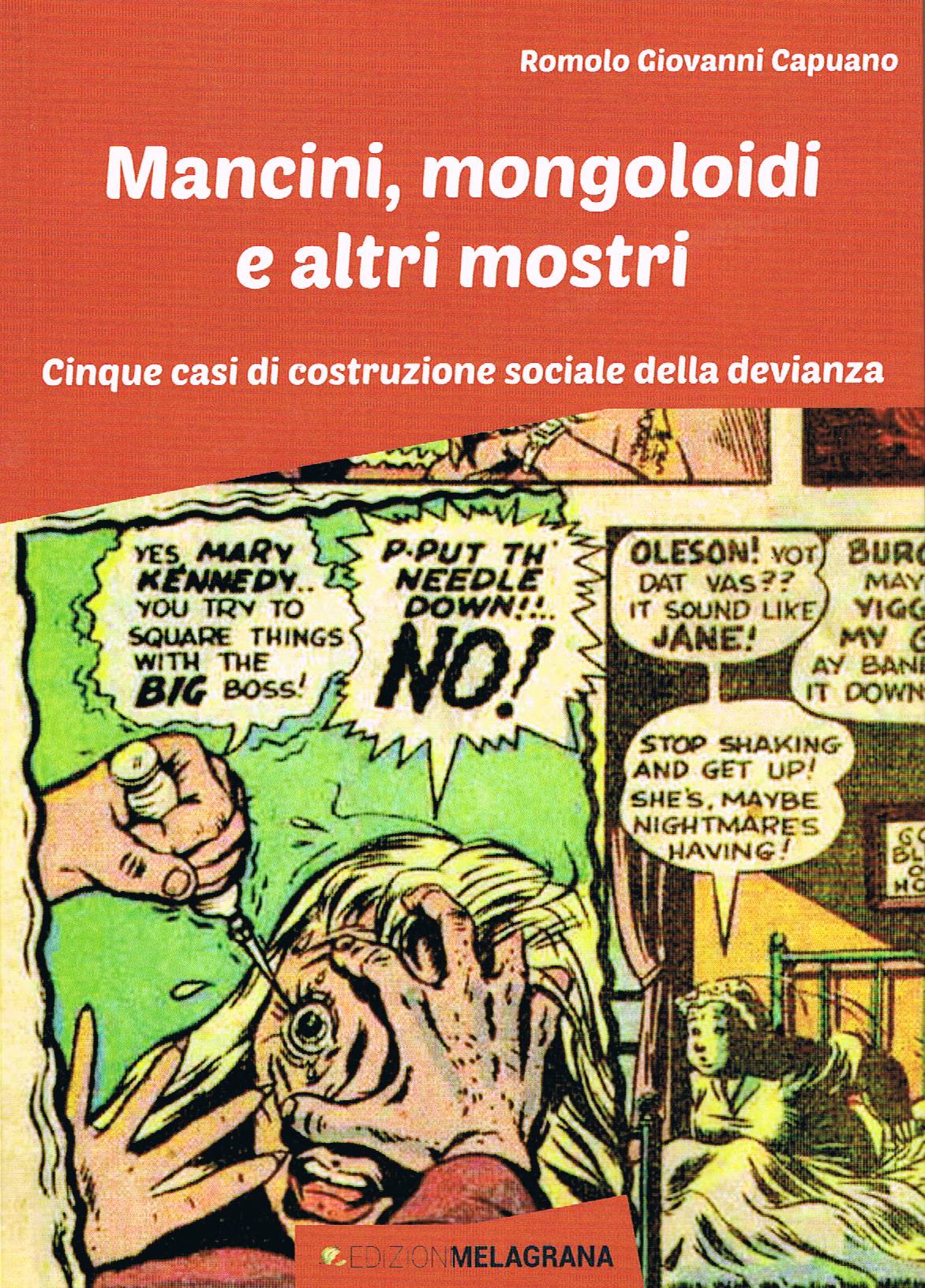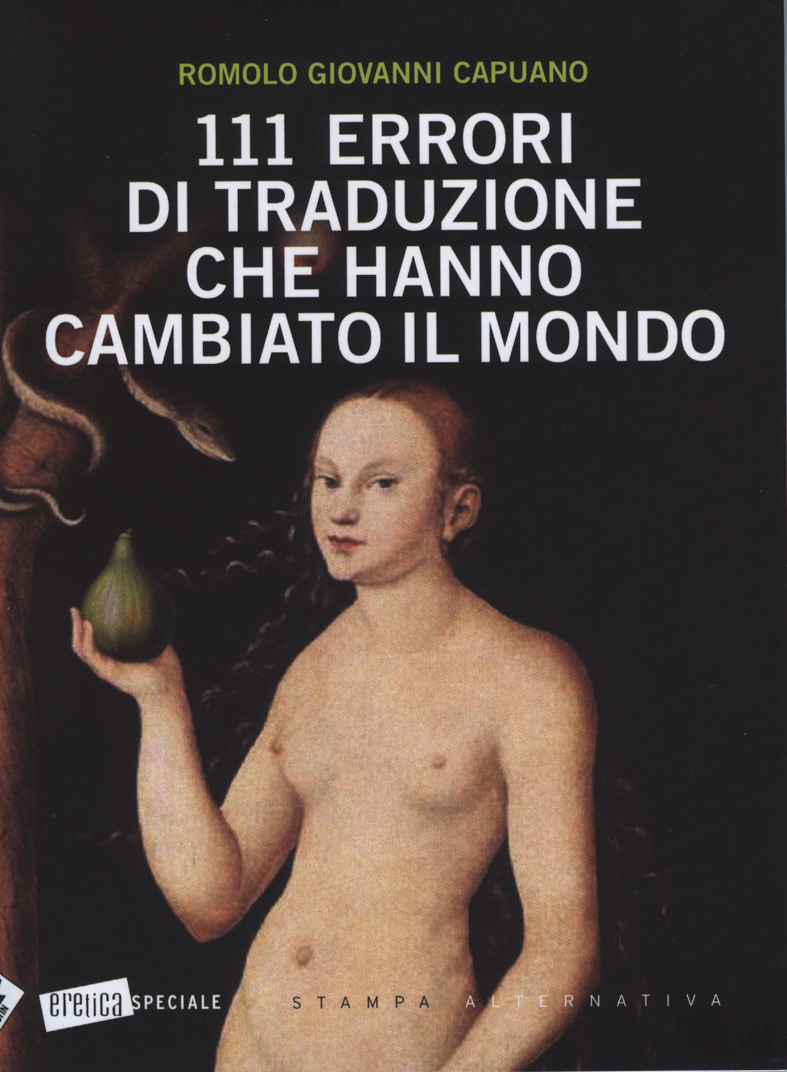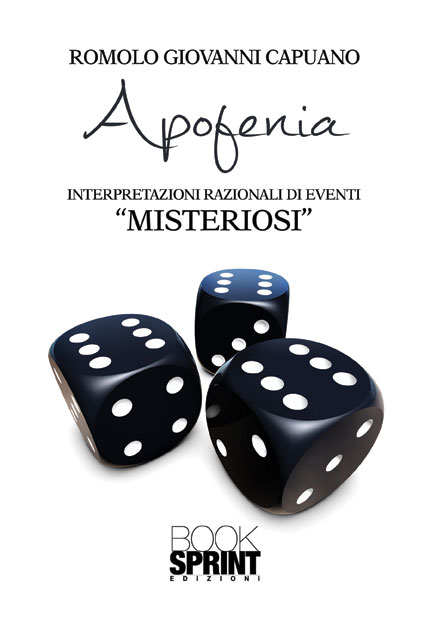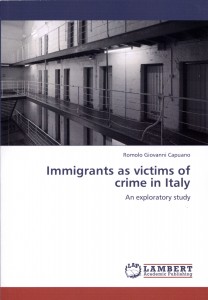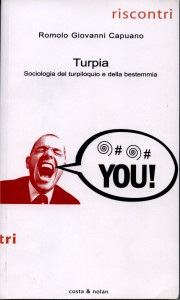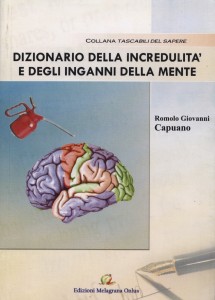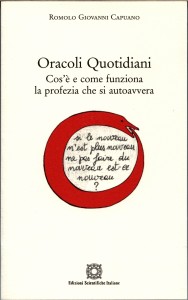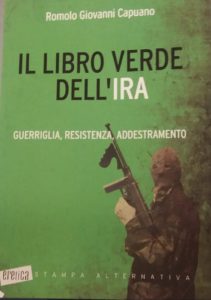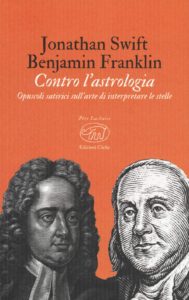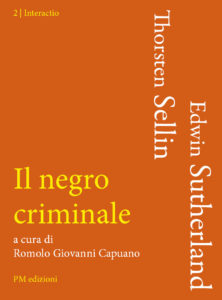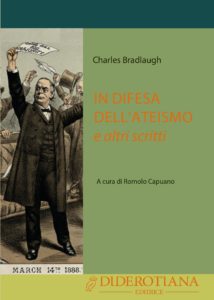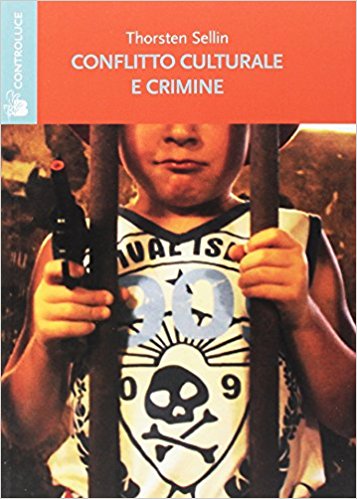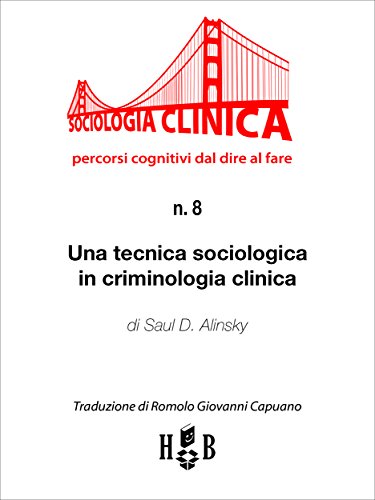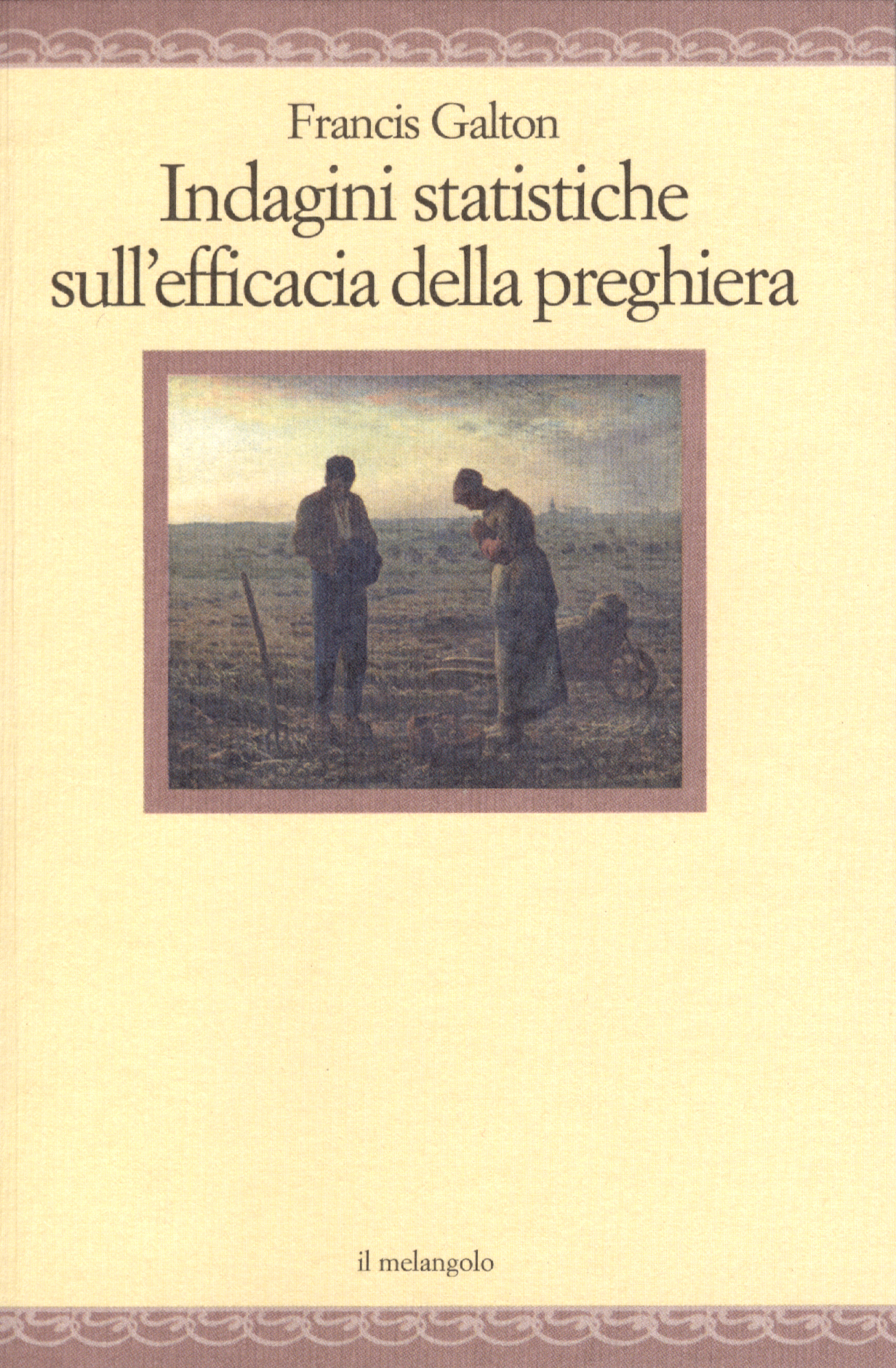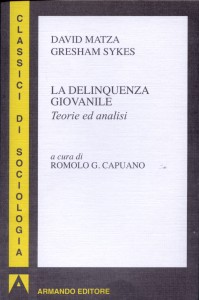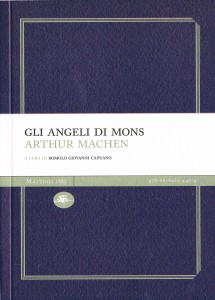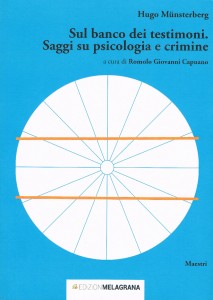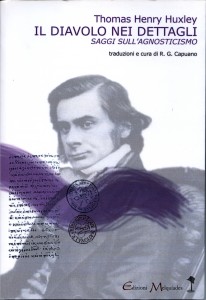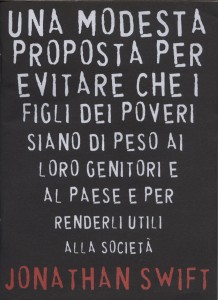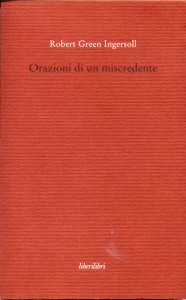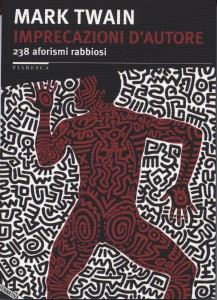In un post precedente, avevo fatto notare come calcio e religione fossero due dimensioni apparentemente distanti anni luce, ma accomunate dalla medesima propensione irrazionale ad abbracciare la parzialità, facendola passare per verità assoluta.
Le analogie tra i due “fatti sociali” non finiscono qui. È anzi possibile proporre una sorta di mappa di corrispondenze biunivoche che dimostra in maniera lapalissiana come le due dimensioni si intreccino fra loro. Questo perché, come dice Gaetano Bonetta in un libro di qualche anno fa – Il secolo dei ludi, Lancillotto e Nausica, Roma, 2000 – “la partita di calcio è pure il momento di una ritualità secolarizzata che si nutre di una forte trasposizione simbolica delle tecniche cultuali delle religioni ebraico-cristiane” (p. 116).
Proviamo a identificare alcune di queste analogie.
Il calendario del campionato e delle coppe europee è modellato su quello liturgico: prevede celebrazioni fisse, ricorrenze, date di nascita e di morte (di inizio e di fine), “festività” a cui è d’obbligo partecipare per “santificare” la propria vita di tifoso (i match clou).
Gli arbitri officiano il rito calcistico come i sacerdoti officiano la messa della domenica. Indossano “paramenti” diversi dagli altri protagonisti, si fanno garanti dell’ordinato sviluppo dell’evento calcistico, infliggono sanzioni ai trasgressori del regolamento come un sacerdote infligge riparazioni a chi si confessa. Il triplice fischio tramite cui l’arbitro sancisce la fine dell’incontro è paragonabile alla formula “Ite missa est” con cui il sacerdote conclude la messa.
Lo stadio è ovviamente un tempio di culto, novella chiesa con tanto di coro (dei tifosi), deambulatorio (il corridoio che introduce i calciatori in campo) e altare (il campo stesso). È qui che si esprime e si celebra il verbo calcistico, così come quello di dio si celebra in chiesa.
La riunione dei tifosi è una sorta di incontro ecclesiale in cui sono stabilite modalità di azione, slogan da cantare, gesti da eseguire. L’organizzazione dei club di tifosi è assimilabile a un’articolazione ecclesiastica.
Il tifo è paragonabile a una forma di preghiera: è caratterizzato spesso da formule fisse, gestualità rituali, inni, invocazioni, richieste alla squadra di “vincere per noi”, moniti morali (“Vergognatevi!” rivolto ai propri beniamini quando questi non ottengono i risultati sperati). Il tifoso, inoltre, è un “fedelissimo” che si identifica pienamente con la propria squadra come il fedele religioso si identifica con il proprio dio.
Le trasferte calcistiche ricordano indubbiamente i pellegrinaggi: loro meta è il “santuario stadiale” e il cammino prevede tappe e percorsi anche molto lunghi. Più è lungo il percorso, più il tifoso acquista meriti, dimostrando la propria inconfutabile dedizione. Il tifoso in trasferta è il “vero” tifoso, così come chi prende parte a pellegrinaggi è un “vero” credente.
Le regole del calcio sono leggi dogmatiche da osservare con zelo pedissequo. Al più si possono interpretare, e di fatto sono interpretate da arbitri, tifosi e giornalisti, ma non mettere in discussione. Anche perché sono regole costitutive, ossia dal loro rispetto dipende la stessa possibilità dell’evento “incontro calcistico”. Allo stesso modo, la celebrazione del rituale liturgico dipende dal rispetto di precise regole a cui il sacerdote e i fedeli si attengono scrupolosamente.
Il VAR appare come un deus ex machina, in grado di decidere l’interpretazione di un episodio calcistico contestato “dall’alto” del suo vantaggio tecnologico, così come, nella Bibbia, Dio interviene spesso a orientare la piega di un determinato evento. Il VAR è assimilabile anche a un oracolo dalle cui labbra arbitri, calciatori e tifosi dipendono per il loro futuro immediato.
Infine, i commenti agli incontri calcistici di giornalisti ed esperti del settore sono paragonabili alle glosse a cui sacerdoti e teologi ricorrono a margine di testi della tradizione biblica e che spesso danno origine ad accesi dibattiti, se non a veri e propri scontri.
Potremmo continuare.
La natura religiosa del calcio – uno dei culti laici di questi tempi – è stata sottolineata da tanti. Qualcuno teme che essa soddisfi a tal punto l’anelito religioso degli uomini da aver saturato quasi interamente questa importante dimensione umana.
A tal punto che pare legittimo chiedersi: E se la religione divenisse col tempo un succedaneo simbolico del calcio?