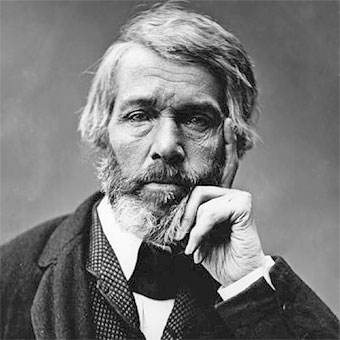I fischietti a ultrasuoni – in inglese, dog whistles – sono strumenti adoperati per impartire comandi ai cani in modo che eseguano determinate operazioni anche a distanza. La loro particolarità è la capacità di emettere suoni praticamente non percepibili dagli esseri umani, ma perfettamente udibili dai cani. Sono, dunque, concepiti in modo da comunicare messaggi solo a un target elettivo, in questo caso i cani.
Per analogia, in politica, dog whistle fa riferimento all’uso di un linguaggio evocativo per comunicare messaggi selezionati a un target preciso al fine di ottenerne il consenso senza suscitare critiche da parte di altri gruppi sociali o schieramenti politici. Le parole o le espressioni dog whistle sono spesso termini ordinari, quotidiani, che però risultano avere una determinata connotazione (spesso positiva) per segmenti politici specifici. Sono generalmente utilizzate per trasmettere messaggi su questioni che potrebbero provocare polemiche senza attirare commenti negativi. Una sorta di insider code dai sicuri effetti propagandistici.
Pensiamo a un termine come “famiglia” o a un’espressione come “valore della famiglia”. Sebbene si tratti di parole ordinarie apparentemente neutre, esse, in realtà, comunicano una “certa” idea di famiglia – tradizionale, antica, anche religiosamente connotata – che rimanda a una visione conservatrice della realtà.
Allo stesso modo, la parola “libertà”, che ha un’immediata connotazione positiva (chi non vorrebbe essere libero?), può comunicare un’idea di avversione nei confronti di tasse e imposte statali e quindi alimentare campagne di orientamento liberista estremo.
Uno slogan come “Dio, patria e famiglia” è comunemente adoperato da esponenti di destra per comunicare una certa idea di Dio, patria e famiglia. “Speculatori finanziari” può essere un riferimento eufemistico per indicare gli “ebrei”.
Così pure, lo slogan “Sono Giorgia. Sono una madre. Sono italiana. Sono cristiana” è diventato il ritornello identitario della nuova destra in virtù delle parole dog whistles “madre”, “italiana”, “cristiana” che, prese di per sé, comunicherebbero solo ovvietà, ma che sono intrise di connotazioni ideologiche ben precise, immediatamente rilevabili a un elettore di destra.
Tramite il dog whistling si introducono, quindi, nel discorso politico delle parole chiave che di per sé avrebbero un significato generico, ma che in realtà nascondono un messaggio sottile, se non subdolo, intenzionalmente diretto a una precisa fascia di elettori, ritenuta in grado di decifrarlo.
Un tempo, durante la Prima Repubblica, il linguaggio involuto e criptico dei politici veniva adoperato per comunicare messaggi “in codice” ad alleati e oppositori, senza che il pubblico capisse. Oggigiorno, i messaggi in codice sono rivolti al grosso pubblico, senza nemmeno “travestirli” con termini tortuosi e incomprensibili.
Tutto è palese nel dog whistling. Ma è un’evidenza ingannevole che spesso cela ciò che con termini chiari non si potrebbe dire. Una sorta di doppiezza verbale alla quale i più non fanno neppure caso perché credono che la politica in fondo sia proprio questo: doppiezza.